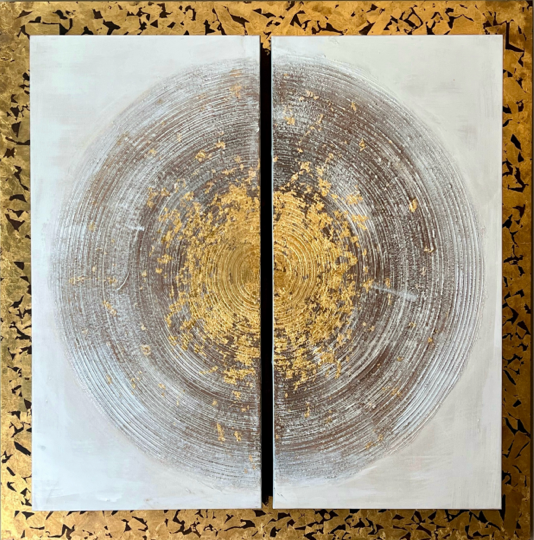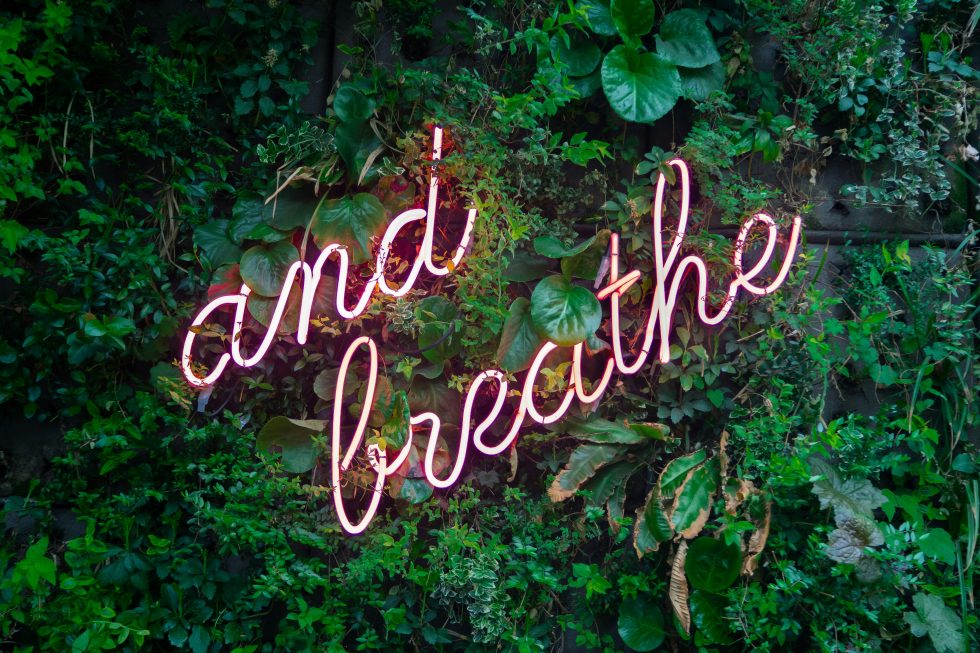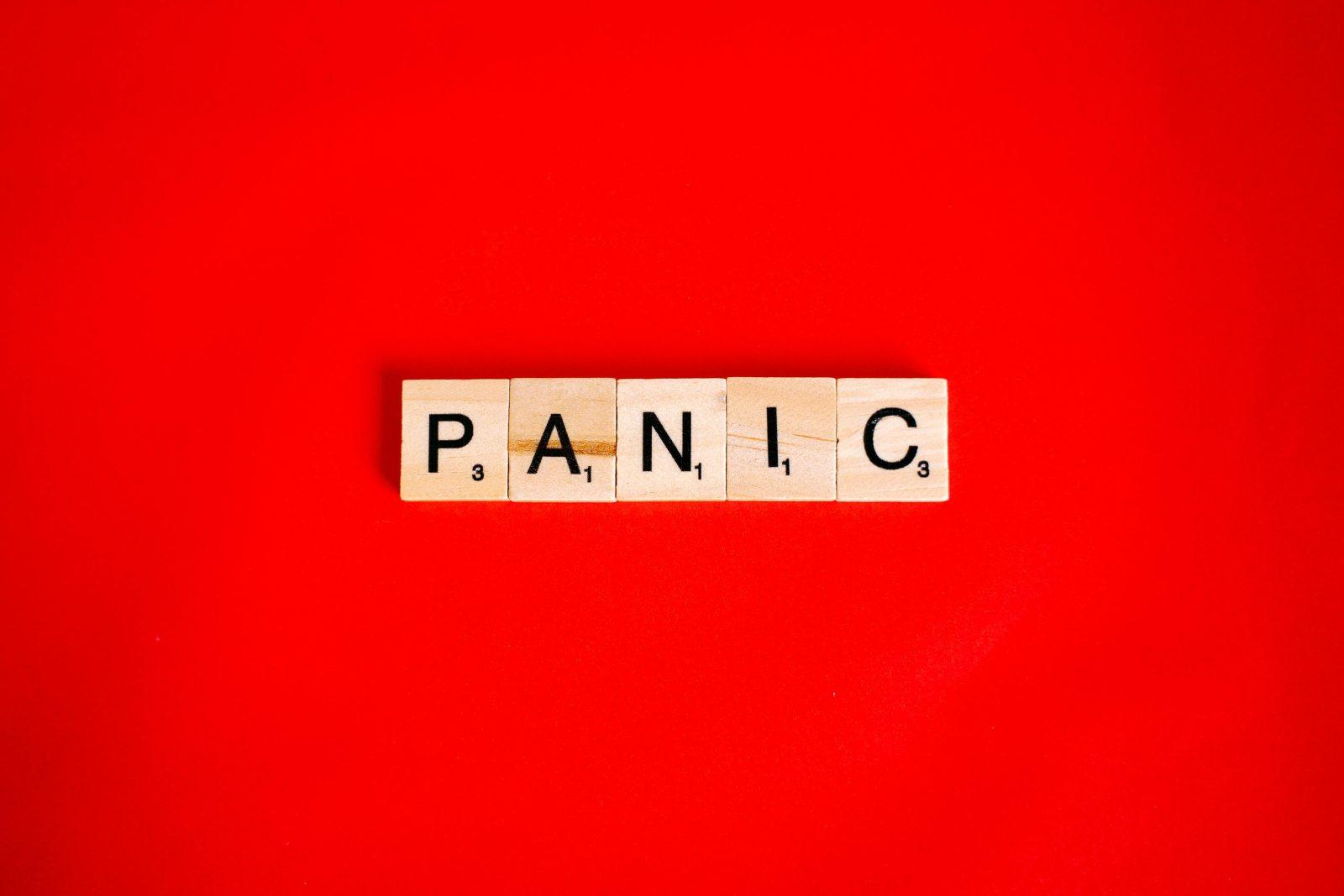
Quando si parla di attacchi di panico, il linguaggio comune tende a descriverli come “ansia portata all’estremo”. In realtà, dal punto di vista neurobiologico, panico e ansia non coincidono: sono due risposte emotive diverse, che il cervello attiva attraverso circuiti distinti. Capire questa differenza è fondamentale non solo per chi li sperimenta, ma anche per la pratica clinica in psichiatria.
L’allarme improvviso del corpo
Un attacco di panico è una scarica improvvisa e incontrollata dei sistemi che regolano la risposta alla minaccia.
Non cresce gradualmente, ma esplode come un allarme che si accende senza preavviso. A livello cerebrale, le strutture più coinvolte sono l’amigdala e soprattutto alcune aree profonde del tronco encefalico, come la sostanza grigia periacqueduttale. Queste zone sono antiche dal punto di vista evolutivo e servono a coordinare reazioni di difesa immediata, quasi automatiche.
L’esperienza soggettiva riflette questa dinamica: il corpo si comporta come se fosse in pericolo di vita, anche quando non esiste una minaccia reale.
L’ansia: attesa e previsione
L’ansia, al contrario, non riguarda il “qui e ora” ma la possibilità di un pericolo futuro.
Per questo coinvolge di più le aree corticali superiori, in particolare la corteccia prefrontale, che elabora pensieri e anticipazioni. L’ansia è quindi più lenta, modulata e spesso collegata a valutazioni cognitive (“e se succedesse…?”).
In altre parole, non tutta l’ansia si trasforma in panico e il panico non è semplicemente ansia più intensa: sono due meccanismi con basi neurobiologiche diverse.
Neurotrasmettitori e sensibilità al corpo
Dal punto di vista chimico, nel panico si osserva una forte attivazione dei sistemi noradrenergici, quelli che regolano l’allerta e l’adrenalina. Al contrario, il sistema inibitorio del GABA funziona meno del dovuto, rendendo difficile spegnere l’allarme. Anche la serotonina ha un ruolo regolatore, aiutando a modulare la soglia oltre la quale i circuiti difensivi si accendono.
Un aspetto interessante è la cosiddetta “ipotesi del falso allarme da soffocamento”: alcune persone con disturbo di panico hanno una sensibilità particolare all’aumento di anidride carbonica nel sangue. Il cervello interpreta anche piccole variazioni come segnale di mancanza d’aria e reagisce con un attacco di panico, anche in assenza di pericoli reali.
Implicazioni cliniche
Queste differenze non sono solo teoriche: hanno conseguenze pratiche. Se l’ansia anticipatoria risponde bene a strategie cognitive e a trattamenti che agiscono sul pensiero e sulla regolazione emotiva, gli attacchi di panico richiedono approcci che intervengano direttamente sull’iperattivazione neurobiologica, sia con farmaci specifici sia con tecniche psicoterapeutiche che lavorano sul corpo e sulla percezione dei segnali interni.
Conclusione
Il panico non è un’ansia “troppo forte”: è un meccanismo a sé, radicato nei sistemi cerebrali più antichi di difesa immediata. Riconoscere questa distinzione aiuta a comprendere meglio l’esperienza di chi ne soffre e a costruire interventi clinici più mirati.